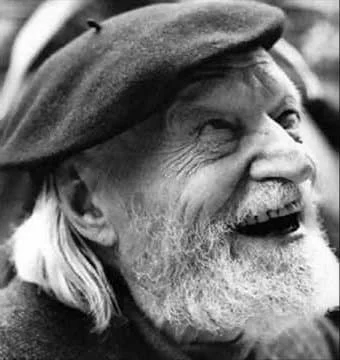La poesia "L'impietrito e il velluto" è stata scritta da Giuseppe Ungaretti, è datata Roma, notte del 31 dicembre 1969 - mattina del 1° gennaio 1970 e fa parte della raccolta Nuove, nella sezione Croazia segreta. Verrà pubblicata il 10 febbraio 1970, giorno in cui il poeta compie ottantadue anni. Ha acquisito popolarità per il semplice motivo che è stata l'ultima poesia scritta dal poeta, ciò non toglie il fatto che sia una poesia stupenda e ricca di significato.
Indice
Testo
Ho scoperto le barche che molleggianoSole, e le osservo non so dove, solo.
Non accadrà le accosti anima viva.
Impalpabile dito di macigno
Ne mostra di nascosto al sorteggiato
Gli scabri messi emersi dall'abisso
Che recano, dondolo nel vuoto,
Verso l'alambiccare
Del vecchissimo ossesso
La eco di strazio dello spento flutto
Durato appena un attimo
Sparito con le sue sinistre barche.
Mentre si avvicendavano
L'uno sull'altro addosso
I branchi annichiliti
Dei cavalloni del nitrire ignari,
Il velluto croato
Dello sguardo di Dunja,
Che sa come arretrarla di millenni,
Come assentarla, pietra
Dopo l'aggirarsi solito
Da uno smarrirsi all'altro,
Zingara in tenda di Asie,
Il velluto dello sguardo di Dunja
Fulmineo torna presente pietà.
Analisi del testo
Per un analisi dettagliata vi proponiamo la spiegazione verso per verso:Il titolo = l'aggettivo "impietrito" viene usato come sostantivo in quanto si riferisce al poeta che è fermo, immobile, come una statua, perché è a un passo dalla morte. Alla durezza della pietra da da contrasto la morbidezza del velluto che fa riferimento alla figura femminile, quella di Dunja.
Ho scoperto le barche che molleggiano / Sole, e le osservo non so dove, solo = qui Ungaretti parla in prima persona e dice di aver scoperto delle barche che dondolano sull'acqua da sole e le osserva. Specifica che è da solo e non sa nemmeno dove si trova. Da qui si può intuire che soffre di solitudine e amnesia.
Non accadrà le accosti anima viva = queste barche potrebbero essere il mezzo per trasportare le anime appena giunte nell'aldilà, come era solito fare Caronte. Il poeta specifica che a queste barche non si avvicinerà nessun essere vivente: saranno usate dalle anime defunte.
Impalpabile dito di macigno = è un dito pesante e allo stesso tempo appena avvertibile al tatto.
Ne mostra di nascosto al sorteggiato = il sorteggiato è colui che è stato scelto dalla morte per morire e con il dito gli vengono mostrati cose che indicano la morte.
Gli scabri messi emersi dall'abisso = questo dito mostra i messaggeri che vengono fuori dall'abisso. Essi sono scabri (ruvidi) perché portano il messaggio della morte. È l'opposto della poesia Commiato, dove dall'abisso emergeva la parola, la poesia.
Che recano, dondolo nel vuoto = questi messaggeri di morti che emergono dall'abisso sono come un'eco di strazio che dondolano nel nulla.
Verso l'alambiccare Del vecchissimo ossesso = gli echi di strazio sono condotti verso il vecchissimo uomo che sta lì a pensare cosa sia quel luogo e cosa ci faccia lì.
La eco di strazio dello spento flutto = l'acqua dove dondolano le barche è uno spento flutto in quanto si tratta dell'acqua dell'oltretomba.
Durato appena un attimo Sparito con le sue sinistre barche = l'eco di strazio è stato di breve durata e insieme a lui sono scomparse pure le barche che ondeggiavano sull'acqua.
Mentre si avvicendavano L'uno sull'altro addosso = Mentre si avvicendavano, si davano il cambio e si inseguivano i branchi delle onde del mare.
I branchi annichiliti Dei cavalloni del nitrire ignari = le onde sono annichilite perché portano il nulla della morte.
Il velluto croato = riferimento alla vecchia di nazionalità croata che la madre di Ungaretti accolse nella casa ad Alessandria dopo la morte del marito).
Dello sguardo di Dunja = gli occhi dell'anziana donna, fanno ritornare in mente al poeta gli occhi di Dunja, una giovane del suo passato.
Che sa come arretrarla di millenni = dice che lo sguardo della donna e lei stessa sembrano provenire da epoche storiche lontanissime.
Come assentarla, pietra = il velluto dà morbidezza alla donna e allo stesso tempo la rende assente (è un Petrarchismo, infatti in Petrarca Laura non è nominata, è presente e allo stesso tempo assente). La donna è assente e così lontana al punto da sembrare pietrificata anche lei.
Dopo l'aggirarsi solito Da uno smarrirsi all'altro, Zingara in tenda di Asie = qui abbiamo la sensazione del poeta di perdersi nel deserto, le tende di Asie rimandano a smarrimenti, non ci sono mete nel deserto, non si possono conquistare approdi, ci si smarrisce.
Il velluto dello sguardo di Dunja Fulmineo torna presente pietà = se prima lo sguardo di Dunja pareva lontano millenni, d'un tratto ora è ritornato presente con la sua pietà.
Figure retoriche
Antitesi = "pietra" (v. 20) e "velluto" (v. 17).Annominazione = "sole...solo" (v. 2).
Ossimoro = "impalpabile" "macigno" (v. 4).
Metafora = "dondolo nel vuoto" (v. 7).
Metafora = "eco di strazio" (v. 10).
Metafora = velluto dello sguardo (v. 24).
Antitesi = "arretrarla" (v. 19) e "torna" (v. 25).